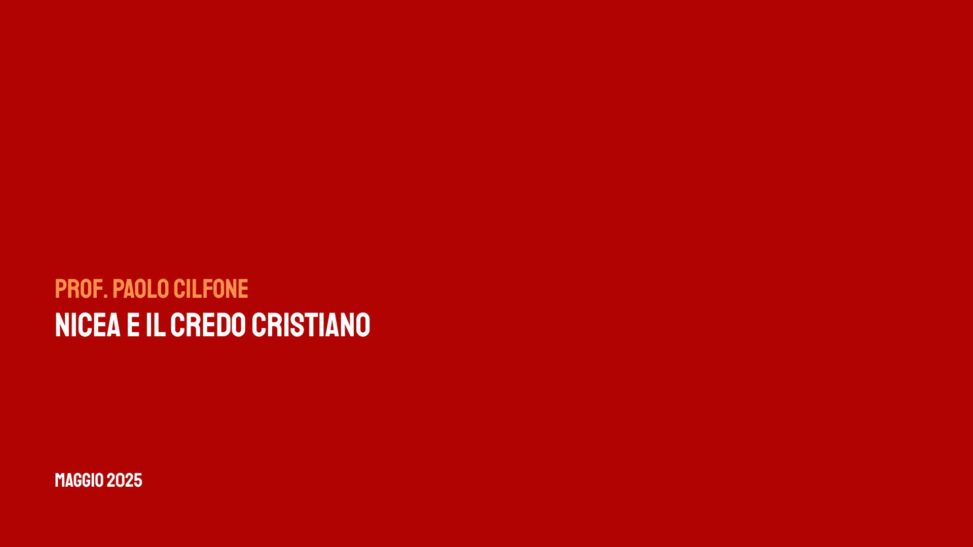Perché il Concilio di Nicea è un punto di svolta nella storia della Chiesa?
Nel 325 d.C., accade qualcosa di unico nella storia della cristianità: per la prima volta, la Chiesa si raduna in un grande concilio ecumenico, convocato nientemeno che dall’imperatore Costantino. È l’inizio di un nuovo capitolo: il cristianesimo, da religione perseguitata, diventa interlocutore del potere imperiale. Ma al centro non c’è (solo) la politica: c’è una questione teologica decisiva. Chi è davvero Gesù Cristo?
La crisi ariana: chi è il Figlio?
Il dibattito che porta a Nicea nasce dalla predicazione di Ario, un presbitero di Alessandria. Ario sosteneva che il Figlio non fosse eterno come il Padre, ma “generato nel tempo”. Per lui, il Figlio era superiore a tutte le creature, ma non consustanziale al Padre. In una parola: non pienamente Dio.
Contro questa visione si schierano vescovi come Alessandro e soprattutto il giovane Atanasio, che intuiscono la posta in gioco: se Cristo non è Dio, non può davvero salvare. Solo chi è Dio può unire l’umano e il divino, e redimere l’umanità.
Il concilio risponde: “Dio da Dio, Luce da Luce”
A Nicea si radunano circa 300 vescovi. Dopo ampi dibattiti, il concilio afferma una verità chiave: il Figlio è “Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre”. Il termine tecnico è homoousios: il Figlio ha la stessa sostanza (ousía) del Padre.
Ario viene condannato, e il suo insegnamento dichiarato eretico. Ma la storia non finisce qui: la polemica ariana continuerà per decenni, fino al Concilio di Costantinopoli I nel 381.
Fede, potere e verità: un nuovo equilibrio
La presenza dell’imperatore al concilio segna un passaggio importante: nasce una Chiesa imperiale, in dialogo diretto con il potere romano. Ma attenzione: la verità della fede non nasce dal compromesso, bensì dalla fedeltà al Vangelo e alla Tradizione. Nicea mostra che la teologia è sempre anche storia, tensione tra fedeltà e novità, tra Vangelo e mondo. Non è mai un’astrazione, ma una risposta a sfide concrete.